|
Le frequenze
dei cellulari sono bioattive e disturbano il nostro sistema nervoso, muscolare
e cardiaco.
I comuni telefoni cellulari
GSM emettono MO a frequenze comprese nell'intervallo di 800-900 MHz o
in quello di 1.600-2.000 MHz. I telefonini analogici funzionano con un
sistema di modulazione della frequenza, mentre quelli digitali emettono
MO pulsate. In pratica, la radiazione usata nel sistema GSM (oggi il più
comune, in attesa dell'entrata in funzione del sistema UMTS che utilizza
frequenze superiori ai 2.400 MHz) consiste di un'onda portante ad alta
frequenza (negli intervalli sopra indicati), che tuttavia "pulsa"
periodicamente con frequenze anche bassissime. Più precisamente
l'onda portante è "modulata", cioè organizzata
in "treni" (serie) di impulsi: ciascun treno "è
lungo" (sarebbe meglio dire "dura"), 120 millisecondi,
ed è formato da 26 impulsi ("vagoni del treno") uno dei
quali è lungo (dura) 4.6 millisecondi. Questi due periodi introducono
nello spettro della radiazione rispettivamente le frequenze di 8,3 Hz
e di 217 Hz (vedi Figura 1 qui sotto):
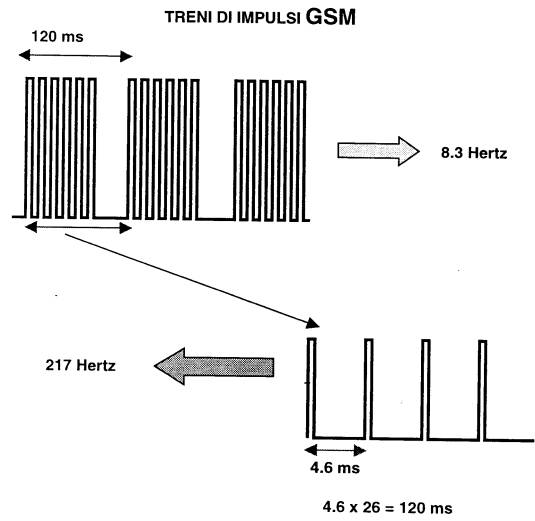
Altre modulazioni, dovute
al modo di funzionamento di altri apparecchi cellulari, introducono frequenze
di 2 Hz e di 17,6 Hz. Tutte queste sono frequenze estremamente basse (ELF),
e alcune di esse sono vicine o coincidono con frequenze biologiche e sono
pertanto "bioattive", cioè vengono riconosciute dai sofisticati
circuiti EM presenti nel corpo umano ( ad es. nel cervello, nell'ippocampo,
nel cuore, ecc.), con le conseguenze qui sotto indicate.
Gli organismi viventi
scambiano continuamente energia con l'ambiente circostante, tramite la
loro attività metabolica: semplicemente per il fatto di essere
vivi essi hanno un contenuto significativo di energia e sono lontani dall'equilibrio
termico. Per questo motivo l'aggiunta anche di piccole quantità
di energia può comportare conseguenze significative per la stabilità
energetica dell'organismo vivente. Una parte dell'energia dei sistemi
viventi serve a mantenere attività elettriche oscillatorie di vario
tipo, nelle quali vengono immagazzinate determinate quantità di
energia. Esempi di tali attività sono i circuiti neuronali del
cervello, che emettono onde EM di diversa frequenza a seconda dello stato
del cervello (veglia, sonno: fase REM e non-REM, ecc.), oppure i circuiti
cardiaci, quelli neuromuscolari, oppure quelli che sovrintendono ai ritmi
circadiani e così via. Questi sono solo gli esempi più familiari,
che la medicina riconosce ed utilizza ormai da tempo, p. es. a scopi diagnostici
(elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, elettromiogramma, per citare
le tecniche diagnostiche più comuni). Forse meno familiari sono
i campi EM a bassissima frequenza (ELF) associati all'elettrochimica del
cervello, all'efflusso del Calcio e ai sistemi neurorecettori, e i campi
EM ad alta frequenza (MO) presenti a livello cellulare e subcellulare,
che presiedono a processi fondamentali, p.es. alla divisione delle cellule.
Tutte queste attività sono caratterizzate da varie frequenze, alcune
delle quali sono molto ben definite (scientificamente si dice che costituiscono
eccitazioni EM estremamente "coerenti"), che vengono definite
"frequenze biologiche".
Come un circuito radio può sintonizzarsi su una frequenza esterna,
cioè riconoscerla e ricevere energia da un'onda EM caratterizzata
da quella frequenza specifica amplificandola ad un livello di intensità
più potente, così i circuiti EM biologici possono sintonizzasi
e ricevere energia da radiazioni esterne. In particolare, se la frequenza
esterna eguaglia o è molto prossima a quella di una bioattività,
quest'ultima può essere influenzata in vario modo, con meccanismi
"non termici" o "a bassa intensità" quali:
1)"amplificazione risonante", che può portare a raggiungere
un livello energetico inaccettabilmente alto da un punto di vista biologico;
2)"interferenza", risultante in un degrado o nell'inibizione
di alcune attività essenziali, p.es. il rilascio di melatonina;
3)"forzatura" di una biofrequenza, magari ad un valore incompatibile
con l'omeostasi;
4)"accensione" in tempi minimi di qualche processo per il quale
la sola fornitura di energia endogena è inadeguata.
Per capire questi fenomeni
basta considerare che il corpo di un uomo "vivo" è un
sofisticatissimo strumento elettronico per il cui funzionamento deve essere
mantenuto un equilibrio omeostatico, frutto di una serie innumerevole
di processi cellulari e molecolari. Questo equilibrio non rappresenta
una condizione stabile, ma è piuttosto una configurazione energetica
di minimo relativo, separata, tramite una debolissima barriera energetica,
da configurazioni energetiche ben più rilevanti, che rappresentano
spesso abissi senza ritorno per la funzione biologica in causa. Si capisce
così come una pur minima interferenza energetica proveniente dall'esterno
possa provocare, col suo pur minimo trasferimento di energia, effetti
drammatici di allontanamento dall'equilibrio omeostatico, in maniera affatto
graduale (tecnicamente si parla di effetti o fenomeni "non lineari",
spesso "altamente non lineari").
E' con questo meccanismo "frequenza-specifico" che un organismo
vivente è capace di "riconoscere" un CEM esterno oscillante
o modulato. Questa abilità di riconoscere un CEM esterno, e di
esserne influenzato nei modi sopra indicati, attraverso la sua frequenza
piuttosto che semplicemente dalla sua intensità, cioè dall'energia
che esso contiene, viene definita come una "influenza informazionale".
Per esempio, negli epilettici foto-sensitivi si possono provocare convulsioni
mediante esposizione a luce resa intermittente tramite modulazione che
produce frequenze tra 15 e 20 Hz: la provocazione della convulsione è
dovuta, non tanto all'intensità della luce, quanto alla frequenza
con la quale essa pulsa. Tale frequenza, essendo molto prossima a quella
che caratterizza l'attività elettrica del cervello di un epilettico
durante una convulsione, permette al cervello di "riconoscerla",
cioè di ricevere informazione (energia EM) e di reagire di conseguenza.
Secondo Hyland, la possibilità di provocare crisi epilettiche negli
animali di laboratorio (ratti) esposti a MO pulsanti, che comprendono
anche la frequenza di 17,6 Hz, e la segnalazione di un aumento della frequenza
di crisi convulsive in bambini epilettici che vivono in prossimità
di stazioni radio-base per la telefonia mobile si basano proprio sul meccanismo
di interferenza sopra descritto.
Altre frequenze bio-attive sono:
1)le frequenze portanti (MO) usate nella telefonia GSM (900-1.800-2400
MHz), che interferiscono con processi biologici fondamentali come la divisione
delle cellule e l'oscillazione degli ioni Calcio e Magnesio attraverso
le membrane cellulari;
2)le frequenze ELF di 2 Hz e di 8,3 Hz presenti nel sistema utilizzato
per "pulsare" le MO dei cellulari, che coincidono rispettivamente
con gli intervalli di frequenza tipici delle onde alfa e delta dei ritmi
elettroencefalografici;
3)la frequenza ELF di 17,6 Hz, anch'essa presente in uno dei sistemi di
pulsazione delle MO dei cellulari, che è prossima alla frequenza
fotoepilettica, ed anche molto vicina alla frequenza di 16 Hz alla quale
l'efflusso del Calcio dalle cellule del cervello mostra un picco drammatico,
ed i neurorecettori eccitatori ed inibitori presenti nel cervello vengono
più intensamente influenzati1
4)La frequenza di rete elettrica di 50 - 60 Hz, che è prossima
alle frequenze di ciclotrone di ioni, ad esempio Sodio, Potassio, Magnesio
e Litio, che si trovano comunemente nei sistemi biologici dove svolgono
ruoli essenziali in molteplici funzioni cellulari (vedi al paragrafo seguente).
E' importante ricordare che la possibilità di interferenze di questo
tipo è ben nota nel contesto della compatibilità elettromagnetica,
tanto che vengono prese misure estreme per evitarla, come la proibizione
dell'uso dei telefoni cellulari sugli aerei, negli ospedali e, più
in generale, in presenza di strumentazione elettronica particolarmente
delicata. La stessa preoccupazione, purtroppo, non viene ancora estesa
all'organismo umano vivente, una situazione che tradisce una ignoranza
colpevole del fatto che un organismo vivente è uno strumento EM
per eccellenza e che, come tale, esso è particolarmente vulnerabile
da una interferenza EM esterna!
In questo contesto occorre sottolineare che, poiché i CEM endogeni
sono coinvolti nel controllo di processi biologici essenziali, è
proprio questa funzione di controllo quella con cui interferisce l'esposizione
a CEM esogeni di debole intensità, in opposizione a quanto si verifica
con CEM esogeni di intensità molto maggiore, che producono danno
alle cellule o ai tessuti. Ci sono, come già si è visto
(7.3.) molti esempi di ripercussioni funzionali importanti da parte di
CEM deboli, p.es.:
1)l'inibizione del processo di riparazione dei danni al DNA che si producono,
sotto forma di rotture dei filamenti, durante il normale processo di replicazione,
ma che in condizioni fisiologiche vengono immediatamente riparati; questa
inibizione può spiegare l'aumento osservato nella frammentazione
del DNA, a dispetto del fatto che l'energia in un quanto di MO è
di fatto insufficiente a causare rotture;
2)effetti sull'efficienza del sistema immunitario, che è il principale
meccanismo di difesa contro l'invasione di agenti patogeni e contro lo
sviluppo dei tumori;
3)l'inibizione della sintesi dell'ormone oncostatico melatonina;
4)i cambiamenti dell'attività proliferativa delle cellule, del
metabolismo del Calcio, ecc.
In tutti questi casi
l'effetto dei CEM di debole intensità è quello di interferire
negativamente su un processo naturale che è essenziale per la prevenzione
di effetti dannosi per la salute, piuttosto che di danneggiare cellule
o tessuti con effetti diretti sulla salute stessa.
|
|

